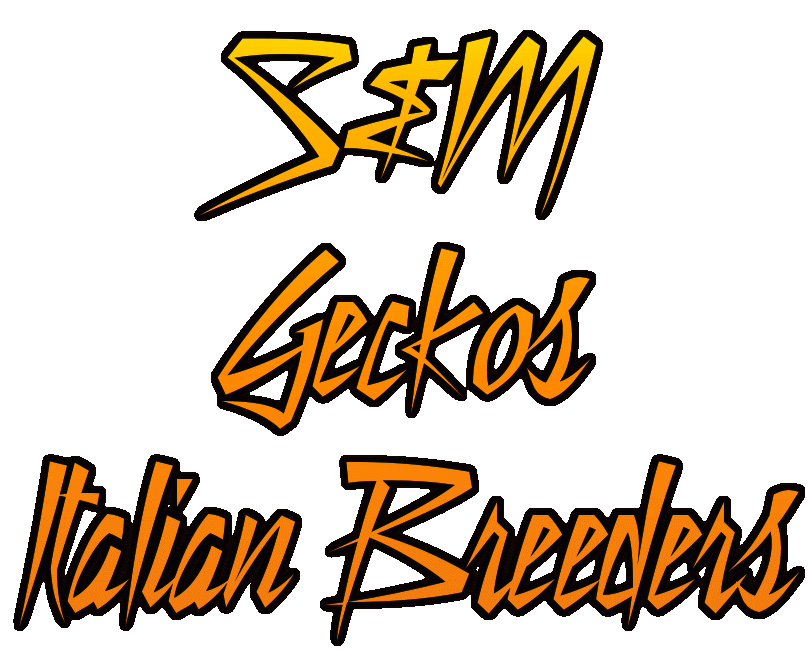ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI SQUAMATI
INFORMAZIONI GENERALI
Il geco leopardino (Eublepharis macularius) è un geco desertico che abita montagne rocciose ed aride pianure caratterizzate da numerosi anfratti e da una scarsa vegetazione(per lo più arbusti). Le temperature molte variabili oscillano da 15°C notturni a un massimo di 40°C nelle ore più calde del giorno. Non è dotato di lamelle sub digitali per cui non è in grado di arrampicarsi su superfici lisce . Raggiunge una dimensione massima di 24/25 cm per un peso che varia tra i 50 e i 70gr di media.Le femmine sono leggermente più piccole e caratterizzate da un colo più sottile.
Dal punto di vista anatomico nella struttura del corpo dei sauri distinguiamo la testa più o meno nettamente separata dal collo, il tronco, i quattro arti e la coda. Ogni arto possiede cinque dita dotate di unghie. Sono in genere presenti palpebre mobili (ma in alcune specie è presente l’occhiale come negli ofidi) ed è presente l'orecchio esterno (privo di padiglione auricolare) o quantomeno una membrana timpanica.I Sauri come gli ofidi non possiedono il diaframma pertanto in questi rettili non si parla di cavità toracica e addominale, ma di un’unica cavità celomatica.
Cute
La cute degli squamati è organizzata in scaglie, piastre o placche in relazione alla regione corporea. E’ molto cheratinizzata e quasi completamente priva di ghiandole; in alcuni sauri sono presenti strutture ghiandolari: i pori femorali e i pori precloacali, più sviluppati nei maschi, con funzione di produzione di feromoni.
La cute, come nei mammiferi, si divide in epidermide, più esterna, e derma, interno. L’epidermide comprende tre strati; alla base si trova lo strato germinativo, la cui replicazione porta alla formazione degli strati sovrastanti. Lo strato intermedio è ricco di lipidi, che rappresentano una barriera contro la disidratazione; lo strato più esterno è lo strato corneo, cheratinizzato.
La cute dei rettili non fornisce isolamento termico. La sua permeabilità è molto variabile secondo la specie: meno impermeabile nelle specie deserticole, più permeabile in quelle acquatiche. La permeabilità cutanea aumenta in caso di contatto prolungato con l’acqua.
In certi sauri il derma presenta delle placche ossificate, dette osteodermi, che rafforzano la pelle rendendola più robusta, e che sul dorso della testa possono fondersi con le ossa del cranio.
Alcuni sauri, presentano nel derma delle cellule pigmentate (cromatofori). Il pigmento di tali cellule può essere concentrato o disperso da segnali ormonali o nervosi, permettendo un cambiamento del colore. Tale capacità ha in parte la funzione di mimetizzare il rettile con l'ambiente che lo circonda, ma serve anche come mezzo di comunicazione tra i conspecifici. Inoltre ha un significato clinico: in alcuni sauri ammalati sono in genere grigi o brunastri. L’intensità della colorazione ha anche un importante ruolo nella termoregolazione e varia quindi con la temperatura ambientale. In molte specie, infatti, la cute diventa più chiara per favorire l'assorbimento delle radiazioni luminose, e più scura per ostacolarla.
La colorazione può avere inoltre scopo difensivo, come i colori sgargianti che avvertono i potenziali predatori della loro pericolosità.
Nei sauri si verifica periodicamente la caratteristica muta (ecdisi) mediante la quale lo strato esterno della pelle viene completamente perduto e rimpiazzato da un nuovo strato di pelle.In genere avviene con il distacco di grossi pezzi, che possono essere ingeriti (cheratofagia).
Occhi
Nei sauri le orbite sono grandi; l’occhio è circondato da un anello di ossicini, detti sclerali, su cui si inseriscono i muscoli ciliari, responsabili della capacità di mettere a fuoco gli oggetti. La pupilla è rotonda nelle specie diurne e a forma di fessura in quelle notturne. E’ presente il sistema naso-lacrimale. Nei sauri è presente anche la terza palpebra, assente invece in tutti gli ofidi. Le palpebre sono ben sviluppate nella maggior parte dei sauri e quella inferiore è più sviluppata e mobile di quella superiore
Orecchio
L’orecchio esterno è molto ridotto in quasi tutte le specie di sauri, ed in genere è presente solo la membrana timpanica, o al massimo un breve condotto uditivo.
L'orecchio ha una funzione sia uditiva sia vestibolare (cioè del senso dell’equilibrio), come nei mammiferi. L'orecchio medio nei sauri è collegato alla faringe tramite la tuba di Eustachio.
Apparato digerente
Lo stomaco è simile a quello dei mammiferi e produce una varietà di enzimi, acido cloridrico e pepsina. L'intestino si differenzia in tenue e colon, e varia in lunghezza secondo la dieta.
Anche il pancreas e il fegato producono una varietà di enzimi e di sali biliari, similmente a quanto avviene nei mammiferi.
Nei sauri il fegato è voluminoso; è solitamente presente la cistifellea, adiacente al lobo epatico destro, e connessa al duodeno da un dotto.
Il principale pigmento prodotto dal fegato è la biliverdina, anzichè la bilirubina come nei mammiferi.
Nella parte finale dell’apparto digerente si trova la cloaca. Consiste di tre compartimenti successivi: il coprodeo che raccoglie le feci, l'urodeo che riceve i dotti del tratto urogenitale e il proctodeo che funge da camera comune di raccolta prima dell’evacuazione. La cloaca si apre all'esterno con una fessura longitudinale.
Perché la digestione possa aver luogo il rettile deve trovarsi ad una temperatura ambientale adeguata, in caso contrario possono verificarsi fenomeni putrefattivi.
Apparato urinario
L’apparato urinario dei rettili squamati (come virtualmente in tutti i vertebrati) è composto da un paio di reni, dagli ureteri e nei sauri dalla vescica urinaria (assente negli ofidi). L'acido urico è il principale prodotto del catabolismo azotato nelle specie terrestri e permette di conservare acqua.
La vescica, come detto, è assente negli ofidi e presente nella maggior parte dei sauri. E' connessa alla cloaca da una breve uretra; l’urina passa dagli ureteri nella cloaca e da qui refluisce in vescica, che è in grado di riassorbire l’acqua.
Apparato riproduttivo
Gli squamata presentano tutti sessi distinti (non vi sono specie ermafrodite) e fecondazione interna. I testicoli sono pari e posti anteriormente ai reni. Sauri e serpenti possiedono due organi per l’accoppiamento, detti emipeni. Sono situati alla base della coda, subito dietro all'apertura cloacale. Durante l’accoppiamento viene utilizzato un solo emipene per volta, che viene estroflesso per essere introdotto nella cloaca della femmina e veicolare lo sperma. Gli emipeni hanno un’esclusiva funzione riproduttiva e non contengono l'uretra.
La femmina possiede ovaie e ovidotti pari. L’ovidotto è diviso in 4 regioni: infundibolo, magnum (che produce l'albume), utero (che secerne le membrane) e vagina.
La maggior parte delle specie di squamati sono ovipare.
In alcune specie di sauri (es. agamidi e gechi) la determinazione del sesso non avviene su base genetica, grazie ai cromosomi sessuali, ma secondariamente a fattori ambientali, in particolare alla temperatura di incubazione: le temperature basse producono femmine, quelle alte maschi. Questo tipo di determinazione del sesso viene detta ambientale o epigenetica.
Apparato cardiocircolatorio e linfatico
I rettili hanno un cuore composto da tre camere (due atri e un solo ventricolo); il ventricolo è diviso in tre sottocamere, i cavi polmonare, venoso e arterioso. Pur mancando una divisione anatomica, nelle tre sottocamere il sangue venoso e quello arterioso non si mescolano, grazie alla presenza di valvole e per la modalità di contrazione ventricolare.
Il sistema linfatico è ben sviluppato. I linfonodi sono assenti ma è presente un’estesa rete linfatica plessiforme. Alla base del collo un seno sacciforme precordiale immette la linfa nel sistema venoso. Fanno parte del sistema linfatico il midollo osseo, la milza e il timo.
Scheletro
La conformazione generale dello scheletro dei sauri ricorda quella dei mammiferi. La colonna vertebrale è flessibile; le vertebre vengono suddivise in tre regioni: presacrali, sacrali e caudali. Nei sauri tutte le vertebre, ad eccezione di quelle cervicali, sono connesse alle coste. Il cinto scapolare è costituito da scapola, coracoide, clavicola e in alcuni casi dall’osso interclavicolare. Il cinto pelvico è costituito da ileo, ischio e pube.
Sia arto anteriore che posteriore presentano cinque dita (sono pentadattili); ciascun dito ha un numero di falangi diverso: dal primo al quinto dito sono rispettivamente 2, 3, 4, 5, 3.
Coda
La coda nei sauri può avere una lunghezza variabile, in alcune specie addirittura superiore a quella del resto del corpo. la coda ha diverse funzioni: prensione, equilibrio, aiuto nel nuoto nelle specie acquatiche, meccanismo di difesa (iguane), riserva corporea con immagazzinamento del grasso (molte specie di gechi).
In molte famiglie di sauri è presente il fenomeno dell'autotomia, ossia la capacità di perdere “volontariamente” la coda quando sono attaccati da un predatore. La coda staccata continua a contorcersi, distraendo l'attenzione del predatore mentre il sauro tenta la fuga.
La separazione della coda non avviene tra due vertebre, bensì lungo un piano di frattura preformato presente nella vertebra. In seguito all’autotomia può ricrescere una nuova coda, che però non è mai identica a quella originale ma presenterà variazioni nella colorazione e nella disposizione delle squame, e spesso queste non si svilupperanno affatto. La coda può essere persa più volte, ma ogni volta a un livello superiore del precedente; la porzione rigenerata, infatti, presenta al posto delle vertebre un asse cartilagineo, che non è in grado di andare incontro ad autotomia.
Termoregolazione
I rettili sono popolarmente definiti “a sangue freddo”, per la loro incapacità di mantenere una temperatura corporea definita grazie ai processi metabolici, come fanno uccelli e mammiferi. In realtà si tratta di un concetto inesatto, in quanto sebbene incapaci di generare calore corporeo (fenomeno detto termogenesi), i rettili sono comunque in grado di mantenere una definita temperatura corporea, che può anche essere di diversi gradi superiore a quella ambientale. Anziché sfruttare la termogenesi, infatti, i rettili sfruttano il calore ambientale, e regolano la loro temperatura interna mediante strategie comportamentali, in pratica esponendosi a fonti di calore esterne (direttamente od indirettamente, all’energia prodotta dal sole). I rettili sono quindi definiti ectotermi. La regolazione della temperatura corporea avviene principalmente con l’esposizione diretta al sole (eliotermia, tipica delle specie diurne) o per conduzione da superfici calde, come rocce riscaldate dal sole (tigmotermia, tipica delle specie notturne).
Questo concetto è di basilare importanza nel mantenimento dei rettili in cattività, in quanto la struttura del terrario deve permettere all’animale di poter regolare la propria temperatura corporea in modo ottimale.
L’ectotermia permette un notevole risparmio energetico rispetto all’endotermia di uccelli e mammiferi che, infatti, hanno un tasso metabolico molto più alto dei rettili; l’ectotermia infatti non richiede di consumare energia per produrre calore corporeo. A parità di taglia, un rettile ha dunque richieste alimentari decisamente inferiori rispetto a quelle di un animale endotermico e può nutrirsi con una frequenza inferiore.
Un limite dell’ectotermia è però rappresentato dalle condizioni ambientali, che devono essere favorevoli al mantenimento di una temperatura corporea adeguata. Per questo i rettili non possono sopravvivere nei climi freddi.
La PBT (temperatura corporea preferita) rappresenta il range di temperatura corporea del rettile entro cui è ottimale lo svolgersidi una determinata funzione metabolica. La PBT è diversa secondo la specie, l’età, lo stato fisiologico (es. gravidanza), la stagione, e perfino la funzione metabolica (digestione, ricerca del cibo, riproduzione…).
Si definisce per i rettili la zona di temperatura ottimale preferita (POTZ) come il range di temperatura dell’ambiente naturale del rettile entro cui l’animale è in grado di mantenere la sua temperatura corporea preferita (PBT). Ogni specie ha una propria POTZ specifica; per la maggior parte dei rettili squamati la POTZ è compresa tra 20 e 38°C, ed in genere per ogni specie varia di 4-10°C.
E’ di fondamentale importanza per la salute del rettile in cattività che all’interno del terrario esso abbia a disposizione un range di temperatura tale da poter mantenere una temperatura corporea ottimale.
I rettili dei climi temperati, quando la temperatura ambientale scende troppo e non è sufficiente a mantenere una PBT adeguata, vanno in letargo, uno stato di metabolismo estremamente rallentato in cui l’animale sopravvive grazie alle riserve corporee precedentemente accumulate (in particolare con l’accumulo di grasso).
Le informazioni sono state prese e sintetizzate dal seguente sito:
http://www.aaeweb.net/schedearticoli/squamata/anatomia_fisiologia_squamata.htm
Per eventuali ulteriori approfondimenti vi invito caldamente a visitarlo!!!